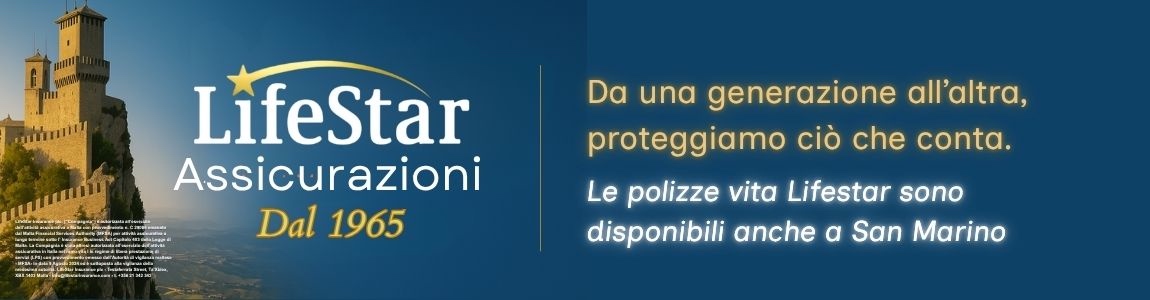Il mondo reale è molto più complesso di quello rappresentato dal sistema binario: maschio/femmina. Non solo ma la distinzione tra sesso e genere non è scontata e accettata da tutti. Esiste infatti una varietà naturale di corpi umani, mentre il genere è una costruzione sociale basata su fattori culturali e ragioni storiche. Concetti su cui ognuno ha una sua idea, non sempre suffragata da dati e valutazioni oggettive, più spesso viziata da pregiudizi e luoghi comuni. Il linguaggio comune ne è una rappresentazione plastica. Per questo, è stato organizzato un incontro pubblico sul tema del linguaggio di genere come strumento di inclusione e rappresentazione.
L’iniziativa è partita dall’Associazione 121, dove il numero corrisponde a quello della legge che nel 2004 ha abrogato l’articolo 274 del Codice penale che puniva le relazioni omosessuali. Fondamentale la collaborazione con l’Università, grazie alla professoressa Maria Elena D’Amelio del Dipartimento di Scienze Umane, vera e propria “one woman show” per la potente lezione su come le parole e le immagini contribuiscano a modellare la realtà sociale.
Una serata che nasce, tra le altre cose, alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “È la prima occasione di quella che noi vorremmo diventasse un’abitudine” spiega Luca Sacanna, presidente dell’associazione 121, anticipando altri incontri pubblici per informare i cittadini su temi molto importanti riguardanti la comunità LGBTQ+
Continua: “Il tema di questa sera è sull’importanza del linguaggio di genere nel nostro quotidiano e nei mass media, che in italiano, ma anche in altre lingue, è molto patriarcale, basato sul maschile, e non rappresentativo di tutta la popolazione. Il fatto di non usare un linguaggio inclusivo è proprio l’elemento che dimostra l’intrinseca abitudine del non dare importanza e peso alle minoranze”. Si dice che la lingua uccide più della spada, è una frase un po’ fatta, ma molto vera e Sacanna aggiunge: “Se noi pensiamo alle parole nell’ambito del bullismo, o anche del cyber bullismo, che sono spesso molto cattive, il loro peso su un pubblico giovanissimo è molto, molto forte. In ogni caso, bisogna sempre fare attenzione a cosa si dice”.

Attraverso l’analisi dei mass media, della cultura e della comunicazione pubblica, la professoressa D’Amelio esplora come le parole e le immagini contribuiscano a modellare la realtà sociale, determinando chi viene riconosciuto e legittimato nello spazio pubblico. La sua lezione attraversa alcuni assi tematici fondamentali: le parole come strumenti per riconoscere e affermare identità e relazioni, attraverso l’uso di pronomi scelti e termini rispettosi; il ruolo dei media, dell’arte e della politica nella costruzione di una società più equa e plurale; come le discriminazioni legate a genere, orientamento, razza, classe ed età si intrecciano nella vita sociale e giuridica.
Dice Elena D’Amelio: “Non esiste un linguaggio di genere, esiste un modo per raccontare, per parlare del genere in maniera rispettosa e inclusiva. Esiste purtroppo anche un modo per parlarne in maniera escludente, o ancora peggio offensiva, a volte anche senza averne contezza”. Spiega ad un pubblico attentissimo e molto partecipativo come rappresentare le diverse identità di genere, quelle che vengono chiamate ormai comunemente le best practice nel giornalismo, nella televisione, negli audiovisivi. “La diversità, sempre e comunque, è una ricchezza. Diversità che esiste e che ha il diritto di essere raffigurata nella sua realtà”. Il problema è che i media non rappresentano la realtà, la creano, e quello che viene recepito poi diventa vero. Ma non lo è. D’Amelio porta degli esempi, come l’uso del maschile, che è sovraesteso in tutto il linguaggio, anche perché non esiste il neutro. Precisa: “Ma è anche vero che c’è stato l’annichilimento simbolico della lingua declinata al femminile. Molto spesso si è scelto di non usare il femminile anche se la lingua italiana lo prevede, per scelte politiche ed ideologiche, non grammaticali. Allora è su questo che bisogna lavorare”.

Parlando di rappresentazione, suo ambito di ricerca, la professoressa spiega l’importanza di creare personaggi che non siano stereotipati, che non si riducano ad una macchietta. “Anche se non vengono prodotte immagini negative, c’è il rischio che risultino limitanti, o escludenti” precisa.
Con passione e altissima competenza, fa capire come il linguaggio possa diventare strumento di partecipazione e riconoscimento, utile a stimolare un dibattito sul modo in cui le parole e le immagini influenzano il modo in cui viviamo e sul loro potere di riconoscere, trasformare e superare gli stereotipi. Che alla fine alimentano solo i pregiudizi.