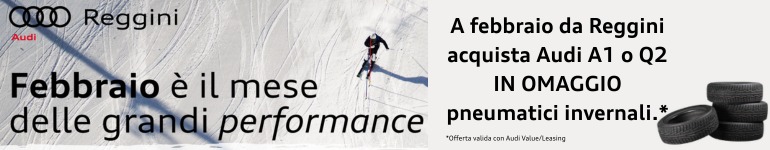A quasi sei anni dall’inizio delle indagini, si avvicina una delle cause più attese nel panorama della lotta alla contraffazione nel settore moda. Il prossimo 26 novembre, il Tribunale di Rimini ospiterà il dibattimento che vede coinvolti numerosi imputati tra persone fisiche e società, accusati di aver gestito una vasta rete di produzione e distribuzione di capi d’abbigliamento con marchi falsificati di grande rilievo internazionale. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza nel 2019, ha portato alla luce un sistema complesso e redditizio, capace di generare profitti milionari attraverso la contraffazione di marchi di moda come Supreme, Balenciaga, Gucci, Nike, Adidas e anche grandi catene di fast food come McDonald’s.
L’operazione ha portato all’unione di due procedimenti giudiziari, con l’obiettivo di fare luce su un traffico illecito che coinvolge anche flussi di denaro sospetti verso la Repubblica di San Marino. Le accuse principali nei confronti degli imputati sono di contraffazione di marchi e ricettazione, con ulteriori sospetti di riciclaggio e auto-riciclaggio. Tra gli indagati figurano imprenditori e collaboratori con sedi operative a Rimini e San Marino, con le autorità che hanno anche monitorato i sospetti movimenti di denaro che attraversano il confine tra Italia e San Marino.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una società sammarinese avrebbe utilizzato un marchio noto negli Stati Uniti per simulare la legittimità della produzione illecita. Tuttavia, questa tesi trova resistenze tra gli avvocati di difesa, tra cui Piero Venturi, che contestano l’ipotesi di contraffazione come sostenuto dall’accusa. La difesa sottolinea che il marchio non sarebbe stato registrato né in Italia né a San Marino e che la commercializzazione dei capi era limitata a questi territori. Inoltre, i legali sostengono che sui capi sarebbero stati apposti marchi “mescolati” o modificati, come la sovrapposizione del famoso baffo Nike con la scritta Adidas, per creare una sorta di parodia piuttosto che ingannare i consumatori.
Secondo i difensori, inoltre, non ci sarebbe stato intento di frode nei confronti del pubblico, poiché sulle etichette dei capi sarebbero state riportate parole come “faking” o “fingendo”, a indicare la natura non ufficiale dei prodotti. Tuttavia, l’accusa ritiene che la presenza di due marchi noti su una stessa maglietta possa comunque indurre in errore l’acquirente, che potrebbe interpretare la combinazione come un co-branding o un’operazione di unione tra marchi di grande prestigio.
L’esito dell’udienza di novembre potrebbe fare luce su pratiche che, se confermate, avrebbero avuto un impatto significativo sull’economia illegale del settore e sulla tutela dei marchi di moda più influenti al mondo.