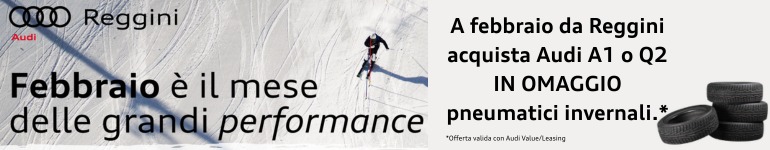La fava (Vicia faba, o Faba vulgaris) è una pianta erbacea annuale, facente parte della famiglia delle Fabaceae e più in generale delle Leguminose (come ceci, lenticchie e fagioli). La pianta ha un busto eretto e grosso, può raggiungere un altezza massima di un metro e mezzo e cresce bene nei climi miti e asciutti come quello del sud-Italia, dove la fava è abbondantemente coltivata per scopi alimentari e come foraggio per gli animali (favetta e favino).
Durante il periodo che va da Aprile a Maggio, la pianta della fava produce dei bacelli, lunghi circa 20-25 cm, contenenti i famosi semi il cui colore e la grandezza può variare a seconda della specie botanica.
Un po’ di storia
 Di antichissima coltivazione, è citata già nei testi biblici, ove il suo consumo viene temporalmente collocato già prima del Diluvio universale. Dato che non necessita di cottura per essere consumato, si pensa che la fava sia stato il primo legume in assoluto che l’uomo abbia mangiato, già prima del 3.000 a.C.
Di antichissima coltivazione, è citata già nei testi biblici, ove il suo consumo viene temporalmente collocato già prima del Diluvio universale. Dato che non necessita di cottura per essere consumato, si pensa che la fava sia stato il primo legume in assoluto che l’uomo abbia mangiato, già prima del 3.000 a.C.
Della fava se ne faceva largo uso già al tempo degli Egizi, Greci e dei Romani. Soprattutto tra quest’ultimi le fave ebbero un grande successo, tant’è che una delle famiglie più importanti della storia romana, i Fabi, presero il nome proprio dalle fave, legume di cui erano particolarmente ghiotti. Lo stesso dott. Mozzi ne decanta spesso le lodi come cibo consumato in grande quantità dai Romani, durante il periodo glorioso della loro espansione.
Il consumo di fave, tra i nobili romani, venne però scemando durante l’epoca imperiale, ma data la sua facile reperibilità e i costi molto bassi, rimase il cibo per eccellenza tra i poveri e nullatenenti.
La fava mantenne pressoché inalterato il suo primato fra tutte le specie di legumi coltivati. A incidere, oltre alle ottime qualità nutrizionali e organolettiche, sono state anche valutazioni prettamente agronomiche: le buone rese; le limitatissime esigenze colturali; la caratteristica di migliorare la fertilità del terreno (cosa che ne ha fatto la principale pianta da rinnovo); l’adattabilità alle varie tipologie di terreno e la bassa incidenza negativa delle basse temperature, della siccità e della prolungata piovosità.
Si ebbe una lieve flessione della coltivazione e del consumo di fave solamente agli inizi del periodo della scoperta delle Americhe, quando in Europa vennero importati i loro parenti stretti, i fagioli. In compenso le fave vennero introdotte anche nel nuovo Continente, tant’è che ancora oggi, specialmente in America latina, se ne fa un ampio uso.
Proprietà delle fave
Le fave sono composte per circa l’85% d’acqua, il 4,5% carboidrati, 5% proteine e 5% di fibre, mentre sono quasi assenti i grassi (circa 0,4%). La fava tra i legumi è uno dei meno calorici, il suo valore energetico è di circa 350 kcal per 100 g di fave.
Tra i sali minerali troviamo molto ferro, tant’è che le fave sono indicate specialmente per chi soffre di anemia, ma troviamo anche: potassio, fosforo, magnesio, calcio, rame, sodio e zinco. Mentre tra le vitamine troviamo soprattutto la vitamina A, ma anche vitamina B1 e B2, la vitamina C e la vitamina E.
Essendo molto ricche di fibre, le fave hanno un lieve effetto lassativo e aiutano la regolarità intestinale.
E’ bene ricordare che con la cottura (bollitura, o cotti al forno), la maggior parte delle vitamine e dei sali minerali delle fave, come di qualsiasi altro legume, vengono persi.
In caso vengano bolliti, sarebbe il caso di non buttare l’acqua di cottura, in quanto ricca di quei sali minerali e vitamine persi dalle fave durante la bollitura. Se proprio volete buttarla vi consiglio di farla raffreddare e usarla per innaffiare le vostre piantine. Infatti l’acqua di cottura dei legumi e delle verdure in generale, è anche un ottimo concime naturale per il vostro giardino e per il vostro orto.
Le fave contengono inoltre Levodopa, un precursore della dopamina che è anche il componente principale di alcuni potenti farmaci, quali il Madopar e il Sinemet, utilizzati nel trattamento del Parkinson. Il principale problema provocato dal Parkinson è infatti la perdita, in alcune cellule nervose cerebrali, del neurotrasmettitore chiamato dopamina che non può essere somministrato direttamente. Non riesce infatti a penetrare nel cervello, si usa perciò la levodopa.
Purtroppo non ci sono ancora studi attendibili e inconfutabili sull’effetto della levodopa contenuta nelle fave nel trattamento del Parkinson. Fatto sta che alcuni pazienti malati di Parkinson hanno ottenuto buoni risultati dal consumo frequente e regolare di fave.
La Scienza non sa ancora spiegare il motivo per cui solo alcuni pazienti rispondano bene alla cura con le fave, mentre per altri, l’effetto è pressoché nullo.
Fave e gruppi sanguigni
Nel libro della dieta del gruppo sanguigno, il dottor Mozzi consiglia il consumo di fave per tutti i gruppi sanguigni, in quanto solitamente ben tollerate, tranne ovviamente per chi è affetto da favismo, una grave forma di anemia piuttosto comune nel bacino del Mediterraneo.
| GRUPPO SANGUIGNO | BENEFICO | NEUTRO | NOCIVO |
| Gruppo 0 | x | ||
| Gruppo A | x | ||
| Gruppo B | x | ||
| Gruppo AB | x |
Usi in cucina
 La fava ha la particolarità di essere l’unico legume che può essere consumato sia crudo che cotto. In commercio lo si trova sia fresco, che essiccato. Nel primo caso le fave (non ancora sgranate) si possono conservare in frigo, ma vanno consumate entro 2, massimo 3 giorni. Inoltre le fave fresche possono essere congelate dopo averle sbollentate per circa 4-5 minuti.
La fava ha la particolarità di essere l’unico legume che può essere consumato sia crudo che cotto. In commercio lo si trova sia fresco, che essiccato. Nel primo caso le fave (non ancora sgranate) si possono conservare in frigo, ma vanno consumate entro 2, massimo 3 giorni. Inoltre le fave fresche possono essere congelate dopo averle sbollentate per circa 4-5 minuti.
Le fave secche si possono invece conservare per molto tempo in contenitori chiusi, posti in un luogo fresco ed asciutto.
Nel caso in cui volessimo mangiarle cotte, una ricetta molto buona e sfiziosa è “La fava in porchetta”, una ricetta molto semplice e tipica della stagione primaverile, in cui si trovano in abbondanza i due ingredienti principali: fava e finocchio selvatico.
Ingredienti: fave sgranate, aglio, finocchio selvatico, e olio d’oliva extravergine.
Preparazione: mettere in padella l’olio, uno spicchio d’aglio tagliato a pezzettoni e, dopo averlo lavato, del finocchio selvatico ben tagliato.
Quando soffrigge aggiungete le fave, salate e coprite con un coperchio che chiuda bene. Controllate spesso se si asciugano troppo ed eventualmente aggiungete un po’ d’acqua. Quando sono abbastanza morbide all’assaggio, aggiustate eventualmente aggiungendo il sale e portate in tavola.
Il favismo
Deve assolutamente evitare di mangiare fave chiunque sia afflitto da favismo, un’anomalia genetica che interessa l’enzima G-6PDH, normalmente contenuto nei globuli rossi, ma quasi del tutto assente in quelle persone afflitte da favismo.
Nei soggetti carenti di questo enzima si può avere un’improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, se e quando ingeriscono fave.
Oltre alle fave, chi è soggetto a favismo deve assolutamente evitare piselli, verbena, varie droghe vegetali e l’assunzione di altre particolari sostanze, quali farmaci analgesici, salicilati, e di alcuni chemioterapici.
La malattia si manifesta in modo improvviso, 12-48 ore dopo il consumo di fave, o anche solo dopo l’esposizione dei pollini di questi legumi. I sintomi sono: anemia grave, crisi emolitica acuta, ittero, emoglobinuria, urine ipereromiche, febbre, dolori addominali, vomito e nausea.
L’anemia grave, l’emolisi e l’ittero consequenziale, sono i segni clinici, talvolta gravissimi, più evidenti.