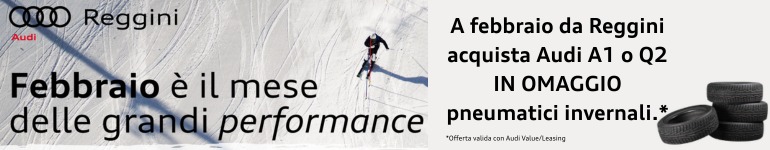La pandemia ha colpito le persone, fisicamente e psicologicamente, e pure le istituzioni costituzionali, materialmente e intrinsecamente. Così come il virus del Covid-19 si è introdotto negli organismi degli esseri umani, in tutto il mondo, così altrettanto si è diffuso nella forma di Stato e di governo alterandone il regolare funzionamento. Sugli effetti giuridici della pandemia si è scritto moltissimo, al punto che circolava la battuta che si era venuto a creare un nuovo settore scientifico disciplinare, lo “IUS-COVID19”. Articoli per lo più pubblicati nelle riviste online ma anche su quotidiani, spesso dettati dall’emotività della situazione emergenziale. In questa maniera si è finito con lo scrivere di tutto e di più nonché il contrario di tutto.
Non certo casualmente, sulla materia è uscito recentemente un libro di Ida Angela Nicotra: “Pandemia costituzionale” destinato a diventare per il futuro un vero e proprio punto di riferimento per chi vorrà riflettere e magari capire meglio quanto è successo. Il testo, segue infatti un approccio metodologico che tiene conto della storia, ma anche della comparazione giuridica dell’emergenza in tutte le sue declinazioni.
Il problema dei problemi è infatti l’emergenza, che si è venuta a manifestare quale conseguenza della diffusione del virus, che attentava alla salute dei cittadini in tutto il mondo. Quindi, punto fermo da cui occorre partire, per qualunque riflessione si voglia fare sul tema, è che abbiamo vissuto un’emergenza senza precedenti, paragonabile soltanto a una guerra mondiale.
Su questo si potrebbe pensare che siamo tutti d’accordo, ma non è così altrimenti non ci sarebbero tutte le differenziazioni di pensiero sul lockdown e sulla vaccinazione a cui ancora oggi assistiamo.
Rimane comunque il problema: come si sarebbe dovuta gestire l’emergenza? Tenuto conto che l’ordinamento costituzionale italiano e sammarinese, ma anche di molti altri Paesi, non prevede una disciplina normativa specifica per tale contingenza.
I veri costituzionalisti affermano però che bene abbiano fatto i legislatori a non prevederla, perché sarebbe stata una norma destabilizzante, del cui corretto uso non avremmo avuto certezza. Si pensi all’uso, ovvero l’abuso, del decreto legge, che è stato un atto legislativo adoperato ben oltre il dettato delle leggi costituzionali, anzi talvolta in aperta violazione, sebbene posto sotto l’ombrello della puntuale previsione che indica: “nei casi di straordinaria necessità e urgenza”.
In fondo, in quasi tutti i Paesi europei e non solo, l’emergenza sanitaria si è potuta comunque gestire anche in assenza di una norma costituzionale che validasse la dichiarazione dello stato di emergenza, con relativa sospensione dei diritti fondamentali, come previsto in altri ordinamenti, per esempio la Francia. Ovviamente non parliamo della Cina, da cui tutto è partito, è dove si è avuto un approccio molto differente.
Nelle democrazie stabilizzate, l’emergenza sanitaria è stata gestita più o meno secondo gli stessi parametri. Lockdown con conseguente limitazioni delle libertà personali si sono avuti dappertutto: leggendo le cronache, non pare che ci siano stati provvedimenti alternativi e migliori tali da potere essere assunti quali modelli di riferimento da emulare. Cosa è successo dunque nel tempo della cosiddetta pandemia costituzionale, come ne parla la Nicotra nel suo testo, dove sciorina le questioni istituzionali e le analizza con puntualità?
Secondo la scrittrice, su territorio italiano in particolare emergono due temi: le fonti del diritto e i rapporti fra Stato e Regioni. Poi ci sarebbe, tra l’altro, il ruolo ridimensionato del Parlamento e l’incredibile proposito di fare votare a distanza i deputati e i senatori. Si inizia con le fonti e l’infinita discussione sui DPCM, quali provvedimenti che non potevano e non dovevano disciplinare comportamenti restrittivi delle libertà costituzionali, perché questo potere lo può esercitare solo la legge, in virtù della riserva, financo rinforzata, di cui gode in costituzione. Legge da intendersi come decreto legge, poiché la legge ordinaria ha tempi di approvazione – complice un datato bicameralismo paritario – poco consoni con la celerità degli interventi emergenziali.
A San Marino, paradossalmente, la situazione giuridica è stata più semplice perché il Consiglio Grande e Generale ha sempre lavorato in presenza, seppure cambiando sede e ha sempre potuto valutare e discutere i decreti legge emessi di volta in volta dal governo. L’unico appunto è stato relativo alla tempistica, perché il decreto veniva emesso in contemporanea alle necessità dettate dall’emergenza mentre il dibattito consiliare avveniva durante le sessioni mensili. Poteva capitare quindi che le ordinanze prescritte fossero superate dalle nuove esigenze dell’emergenza sanitaria o dalla sua stessa risoluzione.
Eppure tutt’ora, quando ormai l’esperienza dovrebbe averci insegnato qualcosa, si parla di costituzione violata. A parte che Gustavo Zagrebelsky ha tranciato di netto queste affermazioni: “Chi dice costituzione violata non sa di cosa sta parlando”, anche i puristi delle fonti sembrano avere dimenticato l’obiettivo verso il quale eravamo tutti impegnati: tutelare il diritto fondamentale della salute dei cittadini e quantunque tutti sappiano che non esiste una gerarchia dei diritti, pare difficilmente opinabile il fatto che la bilancia, in tempo di pandemia sanitaria, penda di più a favore del diritto alla salute. Come è stato scritto: la vita, prima di tutto (sempre Zagrebelsky) e come sottolinea la stessa Nicotra: “Libertà non significa essere liberi di fare ammalare gli altri”. Sul punto, peraltro, si sono chiaramente espressi per il diritto alla vita e all’integrità fisica della popolazione rispetto ad altri diritti, il Tribunale costituzionale tedesco e quello spagnolo con delle pronunce che forse andrebbero rilette con attenzione.
a/f