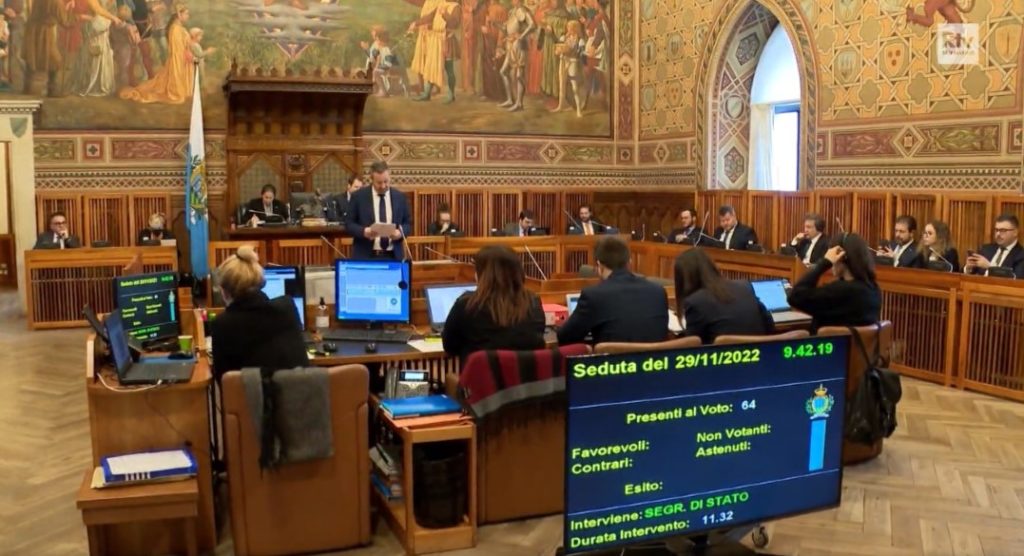Due visioni per la legge di bilancio appena approdata in prima lettura: quella del governo, che propone una lettura ottimistica e speranzosa nonostante le difficoltà; quella delle opposizioni che ne danno un’interpretazione nichilista e di totale sfiducia. Un po’ di ragione e un po’ di torto c’è in entrambe le versioni, a nostro avviso.
Cominciamo dai dati, scritti nero su bianco. Nel testo si fa riferimento a un “ottimo andamento” delle entrate tributarie ed extra-tributarie nel 2021, “con un gettito, in particolare dell’imposta sulle importazioni e dell’imposta generale sui redditi, veramente eccellente, ben oltre le previsioni”. Le prime analisi sull’anno in corso evidenziano dati altrettanto ottimi, addirittura in ulteriore crescita rispetto a quelli del 2021. Un risultato avvenuto senza strumenti e possibilità come quelli del PNRR, ad uso di altri Stati.
Questo la dice lunga sulla capacità di reazione di una piccola economia, qual è quella sammarinese, dopo lo shock pandemico e i traumi generati dalla guerra in Ucraina sui carburanti, sulle energie, sull’inflazione. Fattori che generano pesanti incognite sul 2023, per la cui previsione il governo comunque ha preferito mantenere una linea di sostanziale prudenza, quantunque alcuni dati siano oltre modo positivi. Infatti, la soglia dei frontalieri al di sopra delle 7mila unità (siamo ai livelli degli anni ’90) e un tasso di disoccupazione al di sotto della soglia psicologica fissata normalmente al 4 per cento, stanno a significare che l’economia sammarinese “tira”. Quindi: dati positivi per il settore industriale, ma anche per quello turistico, con numeri superiori addirittura al periodo pre-pandemico.
Le zone d’ombra sono sempre le solite: l’alta percentuale della spesa corrente (nonostante i risparmi avvenuti in vari settori della PA grazie alle riforme della Segreteria Interni); i costi molto alti della sanità e della previdenza sociale (i primi effetti della recente riforma delle pensioni si cominceranno a vedere tra un annetto circa); servizi e infrastrutture in alcuni casi molto arretrati; il costo del debito pubblico e quello delle energie, che presumibilmente avranno conseguenze anche sul bilancio.
Eppure San Marino ha un’enorme risorsa: il risparmio privato. Secondo alcune voci qualificate, le banche sarebbero piene di soldi. Un tesoretto che continua a crescere nonostante la guerra, la crisi energetica, l’inflazione. I sammarinesi sono ricchi perché tradizionalmente nei decenni passati le famiglie sono state parsimoniose, in un paese che cresceva. Non si hanno dati ufficiali sulla portata del risparmio, ma nei report internazionali San Marino viene posto tra quelli con un PIL molto alto, nonostante il debito pubblico stimato in 1,255 miliardi di euro al 31/12/2022.
Questo denaro potrebbe rivelarsi prezioso per sostenere un deciso cambio di passo nelle politiche di sviluppo, che necessitano investimenti tanto immateriali (istruzione, formazione, qualità del tessuto sociale e delle istituzioni pubbliche) quanto tangibili, per recuperare il gap infrastrutturale verso gli altri paesi: collegamenti viari, funzionalità degli apparati energetici e logistici, una digitalizzazione estesa ed effettiva. Usato in una logica virtuosa di investimento, giustamente remunerato, su attività e servizi di interesse generale, questo risparmio consentirebbe al paese di ritrovare quello slancio perduto da troppo tempo. A condizione che vi sia un serio cambio di paradigma nel modo in cui la finanza pubblica e quella privata sono abituate a gestirlo.
Insomma, non ci sarebbe alcun bisogno di un DES (distretto economico speciale), altrimenti detto l’isola dei ricconi, per offrire residenza fiscale a Paperoni non domiciliati. Un progetto che presenta molti rischi, soprattutto in quell’ottica europea che la Repubblica sta perseguendo con una buona progressione. Più terra a terra, abbiamo già avuto un Ali Turki, e non ne vogliamo più.
Ma ritorniamo al risparmio e, in caso, ad una finanza pubblica che può chiedere denaro in prestito ai cittadini per realizzare investimenti e servizi (vedi ad esempio il progetto per il ripristino del trenino bianco azzurro, che potrebbe ricevere un grande consenso da parte dei cittadini). Tuttavia, lo Stato, per fare questo, deve superare le ben note difficoltà a tradurre in risultati concreti la propria spesa. Troppo debito, troppa paura delle riforme che nei decenni ne hanno condizionato la capacità di gestione e di innovazione, incapacità a mettere in ordine le priorità, difficoltà ad effettuare scelte coerenti, dotarsi delle strutture adeguate ad investire e a gestire le ricadute della propria azione. Ivi compreso un processo di digitalizzazione che è partito in molti settori, dalla sanità al tribunale e molti altri settori pubblici, ma ancora incompiuto.
Troppo spesso la politica frena di fronte agli interessi particolari, alla lotta per la bandierina, alla eccessiva burocratizzazione perché non sa istituire un efficace sistema di controlli, al gioco delle parti e, purtroppo, anche di fronte alla mancanza di competenze. L’abbiamo visto nell’avvio del dibattito sulla finanziaria: luoghi comuni, banalità, scarsa conoscenza delle cose, interessi contrapposti mentre l’unico interesse dovrebbe essere quello del Paese. Non c’è bisogno di andare a cercare in giro risorse per finanziare la transizione energetica, l’innovazione tecnologica e quella sociale, la creazione di posti di lavoro ecocompatibili e sostenibili. Le risorse ci sono. Occorre che chi le gestisce impari ad investirle secondo criteri nuovi (l’impatto sociale e ambientale), da innestare sulla vecchia tradizione della spesa di processo (finanza pubblica) e della banca di territorio, riconvertita al digitale.
a/f