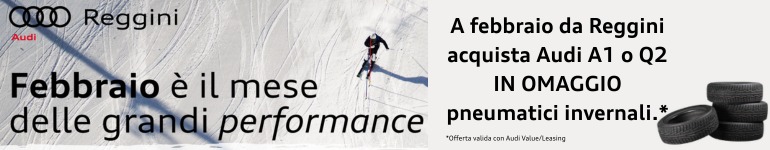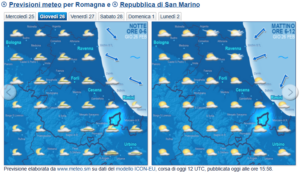C’è una regola giornalistica non scritta per cui se litiga l’opposizione non fa notizia, se litiga la maggioranza si fa il titolone. È la stessa regola del cane che morde l’uomo e l’uomo che morde il cane. Si guarda alla notiziabilità del fatto. Ma se qualcuno esce dalla maggioranza per aggregarsi all’opposizione, ma rimanendo in maggioranza, che tipo di notizia è?
È successo con le due ex Consigliere di Rete, che sono uscite dal gruppo di appartenenza (maggioranza) per formare un gruppo con Rossano Fabbri (opposizione). Poco dopo sono state seguite da Denise Bronzetti, che ha fatto la stessa mossa.
Non facciamo in tempo ad abituarci alla nuova situazione, che Iro Belluzzi lascia NPR per entrare in Libera, ma senza lasciare la maggioranza. Poi c’è la posizione ibrida di Motus, che ormai da tempo fa l’occhiolino a RF, con ampie corresponsioni anche in Consiglio. Siamo perciò di fronte ad azioni e pensieri da opposizione espressi da posizioni di maggioranza.
Abbiamo esaurito le sfumature, o ce saranno altre? Altro quesito: c’è ancora una maggioranza di 44 o siamo di fronte all’inatteso e forse inopportuno ritorno delle maggioranze variabili? Chi può contare sul voto di questi Consiglieri: la maggioranza o l’opposizione?
Il giudizio della gente è impietoso, ma non staremo a sottolineare i commenti. Siamo a metà legislatura, e in qualche maniera è già stato toccato il record dei cambi di bandiera. Non c’è da stupirsi, in Italia è la stessa cosa: in questa legislatura hanno cambiato casacca oltre 150 tra parlamentari e senatori.
Anche la Storia è piena di esempi. Camillo Benso conte di Cavour cambiò alleanza, quando nel 1852 il “connubio” siglato dalla Destra storica con il centrosinistra di Urbano Rattazzi gli spianò la strada verso l’incarico di primo ministro. Non agì diversamente il liberale Giovanni Giolitti, che in maniera assai disinvolta si accordò con i socialisti di Filippo Turati e però sottoscrisse il patto Gentiloni che nel 1913 avrebbe aperto le liste dei liberali ai cattolici proprio al fine di arginare la prevedibile avanzata del Psi. L’elenco sarebbe molto lungo, ma non si può fare a meno di notare che, nonostante abbiano cambiato alleati politici anche molti grandi personaggi, oggi non abbiamo più uomini come Cavour o come Giolitti.
A San Marino, il 18 settembre 1955 Attilio Giannini, eletto come indipendente nella lista del PCS, abbandonò la coalizione governativa. Si venne così a creare una nuova, risicata maggioranza formata da 23 consiglieri democristiani, 5 socialisti, 2 socialdemocratici e l’indipendente Giannini. Il resto della vicenda è passato alla storia col nome “I Fatti di Rovereta”.
Grazie alla mancanza di un vincolo di mandato previsto nella Carta Costituzionale, il cambio di casacca è un atteggiamento antico quanto la storia. Vale poco o niente il fatto che, anche oggi, alcuni partiti facciano firmare ai loro candidati un impegno morale contro questo tipo di comportamento. Passata la festa (cioè ottenuto il seggio consiliare) gabbato lo santu. Anzi, alcuni commentatori li descrivono come: responsabili, costruttori, volenterosi, europeisti, ogni appellativo è buono pur di non utilizzare i vocaboli più “prosaici”, ma più calzanti per descrivere il salto della barricata.
Quando in politica si cambiano bandiere e schieramenti con una facilità inusitata, la premessa deve essere una: non si può pensare che perché lo fanno, o lo hanno fatto, in molti, la pratica debba essere ritenuta ammissibile. Quella del cambio di casacca, ma anche di un repentino mutamento di pensiero sull’operato di un partito, di un governo, di un’intera coalizione, è un qualcosa che certo non giova a prescindere. Per contro, se nessuno si indigna, non c’è motivo alcuno di vergognarsene.
Tuttavia, il venir meno alle promesse e agli impegni presi non aiuta certamente ad avvicinare la gente alla politica e a ritrovare una fiducia ormai in gran parte perduta. Il rischio è che tutto venga ridotto a slogan senza contenuto, che discrimina irrimediabilmente l’intera classe politica.
Sono ormai passati due anni e mezzo da una campagna elettorale che ha visto determinati candidati esprimere giudizi di condanna rispetto ad un modo di governare il paese. Se nel frattempo hanno cambiato idea, avrebbero dovuto rendere conto agli elettori che hanno condiviso quella lettura negativa della gestione del paese. Il vero problema sarebbe quello di chiedere “scusa”, visto che a questo punto si è abusato di un consenso che è stato riscosso perché erano contro quel sistema che oggi senza pudore viene abbracciato.
a/f