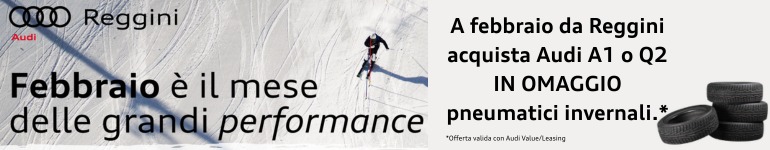Premessa. Grazie al comunicato stampa diffuso da San Marino Group e pubblicato integralmente oggi da l’Informazione di San Marino, è stato possibile, attraverso una rapida ricerca su fonti aperte, ricostruire le connessioni esistenti tra San Marino Group/Starcom Holding AD e la Varengold Bank AG.
Attenzione. Prima di entrare nel merito dell’articolo è fondamentale sapere che Starcom Holding AD, gruppo attivo nei settori assicurativo e finanziario, con presenza in Germania, Bulgaria e Romania, non solo è interessata ad acquisire il pacchetto di maggioranza della Banca di San Marino, ma detiene già dal 2017 una partecipazione pari al 15% del capitale di Varengold Bank AG.
La vicenda che ha coinvolto la Varengold Bank AG rappresenta uno dei casi più delicati degli ultimi anni nella regolamentazione bancaria tedesca ed europea, perché mette in luce l’intersezione tra controlli antiriciclaggio, geopolitica internazionale e la capacità di un istituto finanziario relativamente piccolo di muovere capitali in aree altamente sensibili.
Varengold Bank nasce ad Amburgo nel 1995 come società focalizzata su servizi per investitori istituzionali. Solo nel 2013 ottiene la licenza bancaria piena da parte della BaFin, l’autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, e da allora cresce posizionandosi su due settori strategici: da un lato il cosiddetto “marketplace banking”, cioè servizi a piattaforme fintech e prestiti peer-to-peer, dall’altro il comparto delle transazioni commerciali internazionali, con un focus particolare su import-export tra l’Europa e aree critiche come il Medio Oriente. È proprio questa seconda linea di attività a portarla al centro di una delle più gravi indagini regolamentari degli ultimi anni.
Il 27 giugno 2023 la BaFin, l’autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, impone un divieto severissimo a Varengold Bank AG, vietandole di eseguire transazioni con “payment agents” e con soggetti terzi collegati all’Iran. La misura non è un dettaglio tecnico, ma un atto di straordinaria rilevanza che nasce da un’ispezione approfondita, avviata già nel 2022, e dalla constatazione di “deficit sistematici e gravi” nel rispetto delle norme antiriciclaggio. Secondo BaFin, la banca non aveva implementato controlli efficaci per verificare l’origine dei fondi e soprattutto non aveva messo in atto le misure rafforzate necessarie quando si trattava di transazioni con un Paese considerato “high risk” come l’Iran. A rafforzare la misura, l’autorità ha nominato anche un commissario speciale incaricato di supervisionare ogni attività e di valutare caso per caso eventuali deroghe, laddove la banca fosse in grado di dimostrare che specifiche transazioni non violavano né la normativa europea né i regimi sanzionatori vigenti (BaFin, 2023).
Il nodo centrale dell’accusa non è tanto l’aver violato in modo diretto le sanzioni internazionali, quanto l’aver mantenuto aperta la possibilità che i propri circuiti finanziari venissero utilizzati da attori ostili per scopi non dichiarati. In altre parole, BaFin, l’autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, non afferma che Varengold abbia finanziato il terrorismo o il traffico illecito, ma che le sue carenze nei controlli la esponevano concretamente al rischio di diventare un canale di riciclaggio. È un aspetto sottile, ma fondamentale. L’assenza di colpevolezza penale non elimina l’onere della prevenzione: un istituto bancario non può permettere zone grigie nei propri meccanismi di compliance.
La questione però non si esaurisce in un tecnicismo regolamentare. Diversi organi di stampa e centri di intelligence occidentali hanno sostenuto che la Varengold Bank fosse diventata, di fatto, un hub finanziario attraverso il quale l’Iran riusciva a movimentare ingenti somme di denaro. Secondo un’inchiesta di Politico, la banca sarebbe stata utilizzata da società di comodo iraniane, collegate persino alla Quds Force, il braccio esterno della Guardia Rivoluzionaria Islamica. Il meccanismo sarebbe stato apparentemente lecito: Varengold avrebbe autorizzato transazioni di natura umanitaria, legate a beni non soggetti a sanzioni come cibo e medicinali. Ma dietro queste operazioni, sempre secondo le accuse giornalistiche, si sarebbero celati flussi miliardari riconducibili al commercio di petrolio e al finanziamento di reti collegate all’Iran in Medio Oriente, come Hezbollah o gli Houthi nello Yemen (Politico, 2024; Comsure, 2024).
Varengold ha respinto con forza queste accuse, sostenendo che le sue attività fossero del tutto lecite e circoscritte a progetti umanitari regolarmente approvati. La banca ha più volte ricordato che le proprie operazioni connesse all’IRAN erano limitate a un ambito riconosciuto come eccezione legittima dagli stessi regolatori, ossia quello degli aiuti umanitari. In alcuni comunicati ha sottolineato come le autorità tedesche fossero informate di tali operazioni e come esse avessero contribuito a mantenere aperti canali vitali per la fornitura di farmaci e generi alimentari in un Paese colpito duramente dalle sanzioni internazionali (AML Intelligence, 2024).
L’impatto sul piano finanziario e reputazionale è stato devastante. Alla notizia dell’intervento di BaFin, il titolo di Varengold ha perso circa il 70% del proprio valore in Borsa. Non solo: la banca è stata costretta a ridurre il personale di circa un quinto e ha dovuto rinviare più volte l’assemblea annuale degli azionisti, segno delle difficoltà nel completare i bilanci in un contesto di indagini così penetranti (Bundestag, 2023). Bloomberg ha inoltre riportato che l’autorità tedesca ha individuato “serious anti-money laundering deficits” e ha congelato di fatto le operazioni più sensibili finché non fosse stato implementato un sistema di controllo adeguato (Bloomberg Tax, 2023).
Il caso assume così una portata che va oltre i confini di Amburgo e persino della Germania. Si intreccia con la politica estera, con la gestione delle sanzioni contro l’Iran, con le strategie di contenimento dei finanziamenti al terrorismo internazionale. La percezione, rilanciata da Politico e altri media, che un istituto europeo potesse diventare snodo operativo di capitali diretti a gruppi paramilitari ha sollevato interrogativi sulla capacità delle autorità di vigilanza di prevenire simili fenomeni in tempo utile. Al Bundestag, nel settembre 2023, alcuni deputati hanno chiesto chiarimenti al governo federale, e i documenti depositati hanno evidenziato come la banca avesse utilizzato intermediari esteri non autorizzati, in modalità “non usuali” rispetto agli standard del sistema tedesco (Bundestag, 2023).
Sul piano aziendale, la banca ha avviato una profonda ristrutturazione. Nel 2025 sono state annunciate nuove nomine nel consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di orientare l’istituto verso un modello più concentrato sul fintech e meno esposto alle aree geopoliticamente sensibili. La strategia delineata punta a consolidare la posizione di Varengold come banca di supporto a piattaforme digitali e marketplace finanziari, abbandonando gradualmente quelle transazioni commerciali che in passato l’avevano resa redditizia ma anche vulnerabile (Varengold, 2024).
Il giudizio critico che si può dare su questa vicenda è duplice. Da un lato, la BaFin ha mostrato fermezza nell’intervenire contro una banca che presentava carenze strutturali nei sistemi antiriciclaggio. È una dimostrazione della severità dei controlli tedeschi e del fatto che nessun istituto, nemmeno uno di dimensioni medio-piccole, può ritenersi al sicuro da verifiche penetranti. Da questo punto di vista, l’azione dell’autorità rafforza la credibilità del sistema e lancia un segnale importante a livello europeo, in un momento in cui Bruxelles ha posto la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in cima alla propria agenda legislativa.
Dall’altro lato, resta l’ambiguità sulla reale natura delle operazioni di Varengold. Le fonti giornalistiche che parlano di coinvolgimento indiretto con reti iraniane legate alla Quds Force non sono state confermate ufficialmente. Se queste accuse fossero provate, saremmo di fronte a uno scandalo di portata internazionale, con possibili ricadute anche nei rapporti tra Germania, Stati Uniti e Unione Europea. Se invece fossero infondate, resterebbe l’impressione di un caso in cui un istituto ha pagato un prezzo altissimo per errori organizzativi, senza aver mai realmente oltrepassato i confini della legalità.
La vicenda Varengold mette dunque in evidenza una zona grigia tipica della finanza globale contemporanea. In un mondo in cui i capitali si muovono velocissimi attraverso reti digitali, in cui le eccezioni umanitarie alle sanzioni aprono varchi difficili da controllare, e in cui la pressione geopolitica spinge Stati come l’Iran a cercare vie alternative per mantenere flussi vitali, il rischio che istituti bancari europei diventino anelli inconsapevoli di catene molto più vaste è elevato.
Guardando al futuro, la sopravvivenza e la rinascita della Varengold Bank dipenderanno dalla capacità di ricostruire fiducia. Fiducia nei mercati, negli investitori e soprattutto nelle autorità di vigilanza. Abbandonare operazioni ad alto rischio e concentrarsi su fintech e marketplace bancari è una scelta razionale, ma non sarà sufficiente se non sarà accompagnata da una cultura aziendale nuova, capace di mettere la compliance al centro della strategia. In un contesto in cui la reputazione è il capitale più prezioso, il percorso di riabilitazione sarà lungo e complesso.
In definitiva, il caso Varengold è un campanello d’allarme non solo per la Germania, ma per l’intera Europa. Ci ricorda che i rischi di infiltrazione finanziaria da parte di regimi o gruppi sanzionati non sono teorici, ma concreti e quotidiani. Ci mostra che i confini tra legalità formale e rischio sostanziale sono labili. E ci ammonisce sul fatto che la credibilità del sistema bancario europeo si gioca tanto nella capacità di fare profitti, quanto nella capacità di resistere alle pressioni di un mondo in cui finanza, politica e sicurezza si intrecciano sempre più inestricabilmente.
È ovvio che quanto riportato rappresenta solo ciò che emerge da una prima rassegna stampa e da un monitoraggio delle fonti pubbliche disponibili online. Non spetta certo al giornalismo emettere giudizi definitivi, né stabilire scenari che competono agli organi di controllo. Sarà infatti la Vigilanza di Banca Centrale a dover verificare la fondatezza di queste connessioni, approfondire i profili di rischio e, se necessario, pronunciarsi in modo ufficiale e trasparente.
In questa fase, ciò che appare evidente è che l’operazione STARCOM–BSM non può essere valutata soltanto come un normale passaggio societario, ma richiede un esame molto più attento, alla luce dei legami già consolidati con Varengold e delle implicazioni reputazionali che ne derivano. San Marino ha costruito con fatica la propria credibilità internazionale in materia finanziaria e non può permettersi leggerezze. La scelta finale non riguarda soltanto gli assetti di una banca, ma l’immagine e l’affidabilità dell’intero sistema Paese.