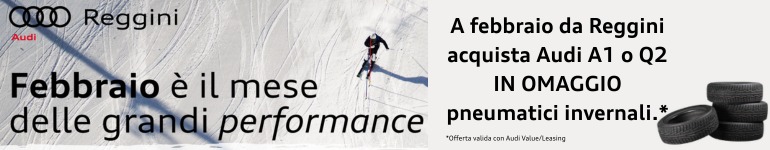Capita a volte, con le persone amiche, di ricordare i fatti significativi della vita, le esperienze, le storie, i momenti indimenticabili. E accorgersi che la memoria conserva dei fatti che – oltre ad averci reso consapevoli di momenti di bellezza – vorremmo raccontare a tutti, perché sono un bene di cui siamo testimoni e non solo custodi.
Un bel film (The giver) mostra il valore della memoria, e la consapevolezza che ciò che è custodito impedisce la schiavitù, rende liberi gli uomini.
Penso che la storia della nostra «Antica terra della libertà» suggerisca a tutti, oltre che per i momenti istituzionali del ricordo, la speranza di un bene possibile, perché reale. Ricordando s. Agostino: «Si isti et istae, cur non ego?»
Un giovane e valoroso generale vandeano, François-Athanase de Charette de La Contrie, ebbe parole lucidissime contro gli ideologi giacobini e rileggerle oggi è molto suggestivo:
«La nostra Patria sono i nostri villaggi, i nostri altari, le nostre tombe, tutto ciò che i nostri padri hanno amato prima di noi. La nostra Patria è la nostra fede, la nostra terra, il nostro re. Ma la loro patria, che cos’è? Lo capite voi? Vogliono distruggere i costumi, l’ordine, la Tradizione. Allora, che cos’è questa patria che sfida il passato, senza fedeltà, senz’amore? Questa patria di disordine e irreligione? Per loro sembra che la patria non sia che un’idea; per noi è una terra. Loro ce l’hanno nel cervello; noi la sentiamo sotto i nostri piedi, è più solida. E’ vecchio come il diavolo il loro mondo che dicono nuovo e che vogliono fondare sull’assenza di Dio… Si dice che noi saremmo i fautori delle vecchie superstizioni… Fanno ridere! Ma di fronte a questi demoni che rinascono di secolo in secolo, noi siamo la gioventù, signori! Siamo la gioventù di Dio. La gioventù della fedeltà» (Grazie ad Antonio Socci che ci ha riportato questo testo).
E, in questo tempo in cui è più facile trovare ragionamenti che spesso sfuggono alla attenzione, ho letto queste considerazioni che mi hanno colpito e interrogato. Perché bisogna pure chiedersi per che cosa vale la pena dare la vita, impegnarsi, che cosa difendere, in questo tempo in cui è più facile lamentarsi che reagire e costruire. Basta pensare a quanto accade nel cammino educativo, o a quell’«inverno demografico» che sembra un destino incontrovertibile, senza che se ne veda una soluzione, anzi.
Scusate, a questo proposito mi sovviene un inciso, letto su un articolo di Ricolfi. «Fra i paesi principali del mondo (popolosi almeno come l’Islanda) ve ne sono ben 15 in cui nell’ultimo decennio il tasso di fecondità totale (numero di figli per donna in età fertile) anziché diminuire è aumentato. E di questi 15 paesi “anomali” ben 8 sono nell’Unione Europea, altri 4 sono ex membri della Jugoslavia, mentre gli altri 3 facevano parte dell’Unione sovietica. Degli 8 paesi UE 3 sono occidentali (Portogallo, Grecia, Cipro), gli altri 5 sono ex comunisti (Romania, Bulgaria, Ungheria, Croazia, Slovacchia) … La diagnosi che si ascolta più di frequente chiama in causa i cosiddetti fattori strutturali: reddito pro capite insufficiente, tasso di occupazione femminile bassissimo, mancanza di asili nido. Di qui la terapia: se si vuole invertire la tendenza occorre moltiplicare i benefit a favore delle famiglie che desiderano avere figli ma non se lo possono permettere. Il ragionamento filerebbe, se non vi fosse un’obiezione grande come una casa: se la ragione della bassa natalità italiana sono le condizioni strutturali delle famiglie, come si spiega il fatto che il tasso di natalità sia altrettanto basso in paesi come il Lussemburgo o la Finlandia, dove il reddito pro capite è più alto, gli asili nido non mancano e le donne lavorano? … È a questo punto che, in molte discussioni sul problema demografico, si affaccia la diagnosi alternativa: è la cultura che fa la differenza. Il tasso di fecondità scenderebbe soprattutto perché i modelli culturali cambiano. Individualismo, narcisismo, fluidità dei rapporti, primato dell’autorealizzazione, renderebbero sempre più problematico il progetto di costruire una famiglia stabile e allevare dei figli: se quando eravamo più poveri facevamo più bambini non è solo perché non c’erano gli anticoncezionali ma è perché eravamo meno centrati su noi stessi».
Ma continuo nel ragionamento iniziato. Che cosa renderà possibile che la memoria di quanto ci ha caratterizzato susciti un impeto di stupore e di nuovo impegno, ridando vita ed entusiasmo alla nostra straordinaria realtà? Sì, perché è evidente che questa piccola Repubblica ha un patrimonio di storia e di valori invidiabili, invidiati ed originali, e quindi una responsabilità di fronte al mondo intero, se è vero che le nazioni hanno un compito (nel passato i credenti ritenevano addirittura che le nazioni avessero un Angelo che le custodiva…) che sarebbe un tradimento non rispettare.
Riprendo una citazione di un articolo di Giulio Meotti che potrebbe aiutarci, per le domande che pone, a trovare una soluzione: «In un libro che sta facendo discutere la Germania, un giovane giornalista e scrittore di nome Ole Nymoen proclama apertamente che non rischierebbe mai la propria vita per proteggere la nazione in cui è nato e cresciuto e che gli ha dato tutte le libertà. Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde (Perché non combatterei mai per difendere il mio paese) è il titolo del libro.
Una specie di manifesto di un pezzo di Occidente.
Se la Germania venisse attaccata, scrive Nymoen, “preferirei cercare di scappare che essere costretto a uccidere”. Lo preferirebbe anche se significasse perdere tutte le proprie libertà?
“Lo dico in tutta franchezza: il diritto di esprimere la mia opinione non vale certo la mia vita”. Nymoen riconosce la differenza tra dittature e democrazie, “ma non sono disposto a morire per questa differenza. Perché in caso di guerra la conseguenza sarebbe la stessa: molto probabilmente perderei la vita”.
Ecco perché siamo un continente talmente abituato alla rendita di benessere e libertà che i politici accettano il ricatto dei petrodollari islamici e svendono i valori occidentali.»
Ma continua Meotti, segnalando una risoluzione del Parlamento europeo: «…La nostra storia è solo una sequela di misfatti. Colpevole e dannato uomo bianco europeo, la tua coscienza può essere illuminata solo dalla lampadina dell’odio di sè. Di fronte a questi “orrori del passato”, dice la risoluzione europea, l’unico riscatto possibile consiste nell’“abolizione dei parametri nazionali”. È necessario “anteporre la storia europea e mondiale a quella nazionale e porre l’accento su una comprensione sovranazionale della storia”; riformulare “libri di testo di storia transfrontalieri e transnazionali” per “abbattere le barriere nazionali”; “sfidare gli stereotipi e i sacri simboli delle storie nazionali”. L’approccio alla storia sarà “multiculturale e attento al genere”, al fine di “lottare contro l’emarginazione di gruppi sociali sottorappresentati nella storia”.
Forse, se accettiamo la logica di Ole Nymoen o le considerazioni programmatiche della risoluzione citata potremmo perdere ogni speranza. Ma non è quello che vuole il nostro cuore e che le amicizie costruttive ci suggeriscono. Se i nostri amici polacchi gridavano «La Polonia non è morta finché noi viviamo» certamente anche San Marino potrà essere quel faro di vita e bellezza se noi saremo «vivi». E questo non potrà essere da soli, perché è l’unione che fa la forza.
don Gabriele Mangiarotti