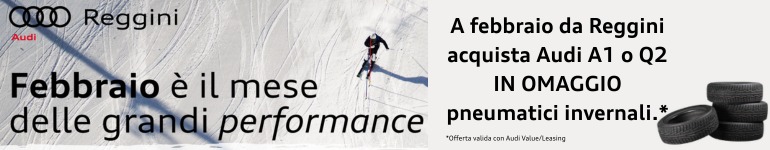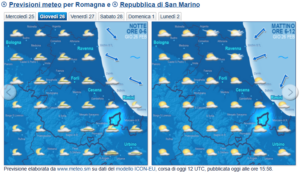Due anni di pandemia ed ora la guerra hanno portato cambiamenti nel profilo delle vendite, negli equilibri della filiera e di conseguenza anche nei consumi. Due anni di discontinuità hanno avuto pesanti effetti nelle dinamiche di sell-out e out-of-stock (vendere tutto, esaurire gli stock).
Le “scosse” della pandemia che nel 2020 hanno cambiato le nostre abitudini e, di conseguenza, condizionato gli andamenti di vendite e trend del largo consumo sono state: il lockdown, le limitazioni alla mobilità, gli accessi contingentati ai punti vendita, il lavoro in smart working che a sua volta ha ridotto i consumi fuori casa (in particolare quelli legati a bar e ristoranti), la crescita dell’e-commerce, l’introduzione della didattica a distanza.
In mezzo a tutto questo, è scoppiato il fenomeno del caro carburanti e della riduzione delle materie prime. Si è subito capito che, oltre a cause oggettive, sono intervenute bolle speculative rispetto alle quali anche gli interventi dei governi hanno avuto ben pochi risultati. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha amplificato in maniera esponenziale tutti questi problemi aggiungendo quelli relativi al rifornimento di energie, nonché di alcune materie prime alimentari come il grano e il mais.
La rivoluzione dei consumi non è fenomeno esclusivo dei giorni nostri, è un evento socioeconomico già verificatosi nella storia. Un esempio eclatante avvenne anche nel XVIII secolo: i prodotti che giungevano dai nuovi continenti venivano utilizzati non solo dalle classi elitarie e borghesi, ma anche da quelle popolari. Gli articoli più richiesti furono il tè, lo zucchero, il caffè, la cioccolata e il tabacco, che ebbero un’espansione rapidissima. Questo tipo di commercio cambiò la geografia delle potenze commerciali.
Pensiamo anche cosa successe dopo la Seconda guerra mondiale, con il miracolo economico e l’insorgere dell’età dell’abbondanza. L’impatto del modello americano sulla nascita di una società dei consumi europea e il confronto con il modello di una “via socialista al consumo” hanno segnato una profonda evoluzione.
Il punto centrale di questi esempi sta nella considerazione che la rivoluzione dei consumi avvenuta in passato ha sempre identificato il momento di uscita dalla povertà e di liberazione dal bisogno per vaste fasce della popolazione, creando nuovi ceti socialmente e politicamente rilevanti. Tutto ciò ha avuto un effetto di stabilizzazione delle democrazie postbelliche. Nella competizione est-ovest non si giocava solo una partita di missili, di potenza militare, di “libertà contro il totalitarismo”. La difesa della democrazia poteva assumere un significato più profondo, e insieme più immediatamente percepibile alle masse, perché alla democrazia era connesso quel diffuso miglioramento delle condizioni di vita di tanti, con cui il “socialismo reale” semplicemente non poteva competere.
Oggi, la competizione est-ovest non lascia presagire scenari di nuova ricchezza diffusa. Anzi, pare che il nuovo paradigma sia: abbassare i riscaldamenti e ridurre la velocità. Ci sono governi che già ipotizzano queste soluzioni nei loro piani anticrisi. L’embargo del gas russo diventerà una realtà (anche se contrastata e non gradita da tutti i membri UE) e il governo italiano pare abbia già un piano per ridurre i consumi in caso di emergenza. “Preferite la pace o il condizionatore accesso tutta l’estate?” aveva già detto pubblicamente il premier Mario Draghi.
Indicazioni sono già state espresse per abbassare il termostato negli edifici pubblici, nei centri commerciali e perfino nelle abitazioni. Ridurre la velocità delle auto potrebbe aiutare ad affrontare la penuria di petrolio, finché tutto il parco macchine non sfrutterà l’elettricità. Ma anche in questo caso ci sono problemi, perché l’energia elettrica va prodotta, o va comprata.
San Marino non si è ancora espresso su certi punti e si è limitato ad un contenuto aumento delle bollette, per altro non paragonabile a quanto avvenuto in Italia. Di fronte al forte rincaro dei prezzi e alla ripresa dell’inflazione, molti, anche appartenenti alle fasce più abbienti, hanno modificato le loro abitudini relativamente ai consumi: si guarda al costo dei prodotti, ma anche alla sostenibilità della produzione. E se le aziende vogliono continuare ad essere competitive devono allinearsi ai nuovi trend di consumo e investire in una trasformazione che parte dalla ridefinizione della propria identità, altrettanto dovrà fare la politica. La quale dovrà saper guardare ai nuovi modelli e cambiare i suoi vecchi paradigmi.
a/f